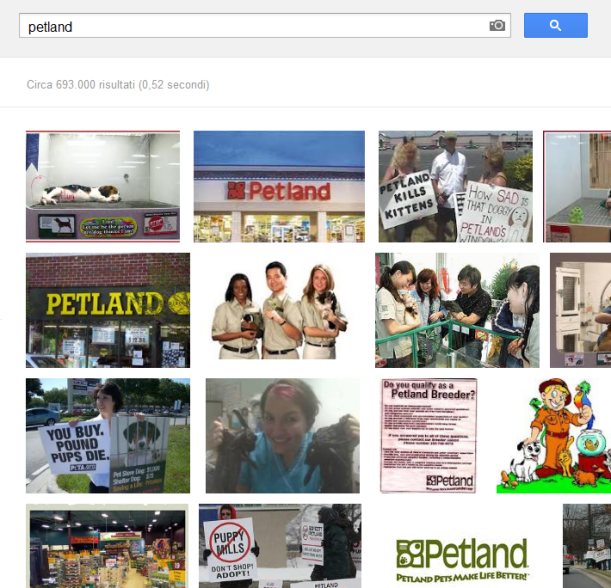Essendo sia un consumatore molto attento sia un appassionato di tecnologia e affini, un geek per intenderci, rimasi subito affascinato quando uscì questo coso qui.

Diciamo che l’idea era talmente tanto innovativa e la tecnologia talmente affascinante da non poter trattenere un forte desiderio di acquisto. Non che ci dovessi fare granché, però diciamo che l’attrazione per il prodotto era molto alta.
Come è andata a finire poi?
Semplice: non solo non ho mai comprato un Segway, ma non ci sono nemmeno mai salito sopra.
Mi sono sempre chiesto perché alla fine tutta la campagna di marketing, gli articoli e i servizi su questo prodotto si siano rivelati poi una bolla di sapone. Perché una cosa che doveva essere così innovativa e coinvolgente sia poi finita in un flop, relegando il proprio uso alla security dei centri commerciali, o a qualche negozio che vuole avere commessi o magazzinieri un po’ più cool del solito.
Cercando in giro ho trovato un articolo di InnovationManagement in cui Paul Sloane spiega proprio perché il Segway ha fallito, identificando cinque punti deboli del prodotto.
Vediamo quali sono, e quale commento si può dare dal lato del consumatore del prodotto.
-
Le aspettative erano troppo alte
Questo è un punto dolente che ha causato, e causerà, il fallimento di tantissimi prodotti e l’infelicità di tantissimi consumatori. Uno dei marchi più colpiti, da rumors, speculazioni e voci pre-uscita è Apple. Il punto è dolente perché spesso i produttori o esaltano troppo i loro prodotti, o creano un hype prima della presentazione troppo alto.
Mentre comprendo che molte voci e commenti non si possono evitare, vanno però mitigate. Penso sia compito di un buon reparto marketing di un’azienda cercare di monitorare e contenere (laddove possibile) i commenti non reali o le voci esagerate, che possono ingenerare aspettative troppo alte. Pronte solo per essere smentite all’uscita stessa del prodotto. Sloane dice esplicitamente che un’attività di PR è sempre valida, ma in questo caso è stata overdone. Cioè chi ha curato la parte marketing del lancio del Segway è caduto nella sua stessa trappola, credendo troppo nel prodotto e presentandolo come una rivoluzione, come il futuro dei trasporti.
Quando si è scoperto che era solo un gadget bello e costoso, la delusione ha preso il sopravvento sui lanci pubblicitari.
-
Era un prodotto, non una soluzione
Come ogni strumento di trasporto, ma anche come ogni gadget, il consumatore necessita di una definizione del contesto di utilizzo.
Faccio un esempio: se ho una fotocamera digitale e ne compro una col GPS integrato è perché voglio che inserisca già le coordinate delle foto quando le metto su Flickr, ma questo avviene perché ho già delle strutture a supporto del contesto. Qualora avessi acquistato un Segway, dove sarei andato? Dove avrei caricato le batterie? L’avrei potuto guidare in altro percorso che non sia dentro un centro commerciale? Difficile a dirlo, ma sicuramente la mancanza di definizione del contesto, la causa generante di tutte queste domande, ha come effetto un forte freno all’acquisto del prodotto.
-
Non aveva un target specifico né rispondeva ad una necessità specifica
Una delle capacità, prendendo sempre come esempio Apple, di Steve Jobs era quella di capire cosa volesse la gente.
Qui ci troviamo di fronte ad un gadget molto costoso, che però non risponde ad una reale esigenza del mercato (vedi anche il punto 2). Mi serve davvero? Ma per farci cosa? Per andarci dove?
Anni fa molta gente, me compreso ovviamente, era assolutamente disponibile a comprare un iPod da un milione e mezzo di lire per avere con se migliaia di canzoni. Io stesso comprai per una cifra simile uno dei primi smartphone, il P800, per avere praticamente un computer sempre appresso. Ma il Segway?
Alla fine si è scoperto, appunto, che la necessità era di gestori di centri commerciali e che il target erano addetti che dovevano muoversi velocemente. Un po’ pochino no?
-
Era un’invenzione, non un’innovazione
Abbiamo capito che innovazione è qualcosa che rientra in un contesto, recepisce un’esigenza specifica e, risolvendola, coinvolge pienamente il proprio target.
Il Segway era una grande invenzione (il meccanismo di guida e stabilità su due sole ruote, con motore elettrico), ma poco altro in più. Ed essendo un’invenzione è stata trattata come tale fino alla sua presentazione al pubblico: è stata tenuta segreta, non è stata provata su strada, non sono stati fatti focus group né ricerche di mercato, né si è cercato in qualche modo un feedback degli utenti.
Anzi alla fine, racconta Sloane, i suoi inventori si sono stupiti che la gente lo criticasse. Pensavano di aver inventato uno strumento estremamente cool, quando veniva percepito come dorky.
-
Le normative
Il problema forse più spinoso è quello lasciato per ultimo: il Segway non era a norma in gran parte degli stati in cui fu presentato.
Ora, il problema del rispetto delle normative è tanto più grave quanto un prodotto è rivoluzionario. Se infatti sviluppiamo e presentiamo un qualcosa che cambia radicalmente il nostro modo di vivere o di fare una cosa fatta in precedenza, allora è molto probabile che la legislazione attuale non sia pronta a riceverlo.
Questo problema però, esattamente come nei punti precedenti, non fu analizzato preventivamente. Anzi, non ci pensarono proprio! Il risultato fu che quelli che avevano comprato il Segway si ritrovarono a non poterlo usare sui marciapiedi ad esempio, luogo ideale perché per strada sarebbe stato troppo pericoloso.
La sintesi di Sloane, che condivido appieno, è che un prodotto per essere realmente rivoluzionario e non una semplice idea (anche geniale eh) realizzata e venduta, deve prevedere delle fasi iterative e dei ragionamenti sui suoi punti di forza e debolezza prima di essere immesso sul mercato.
L’assenza di questa fase viene comunque percepita dai consumatori, che si trovano in una situazione di dubbio e incertezza rispetto ad un prodotto che magari vogliono comprare. E il dubbio e l’incertezza, se non chiariti bene in fase di acquisto, possono inibirlo, e lasciare il prodotto sullo scaffale.
Questa è sicuramente responsabilità dei settori marketing, ma anche di chi sviluppa un prodotto o una soluzione, di chi la pensa e la costruisce. Perché si fa presto ad avere un’idea e magari anche riuscire a commercializzarla.
Però poi bisogna anche venderla, e per venderla serve che piaccia, sia utile, e sia usabile.